.
.
.
 Brevi estratti da “Valutazioni sulle Scienze Informatiche”, di Albert Sinatra.
Brevi estratti da “Valutazioni sulle Scienze Informatiche”, di Albert Sinatra.
Dal primo capitolo: Qui a Tangeri le persone non si pongono le stesse questioni che invece turbano la vita di noi occidentali. L’esistenza per questa gente si divide tra valori e interessi. Il valore è il fine da raggiungere (una bella casa, una macchina, una posizione sociale rispettabile), gli interessi sono il mezzo per perseguirli. Un impiegato, ad esempio, sarà interessato a frequentare colleghi ben inseriti nella società, sperando di poter un giorno presentare la sua primogenita al figlio del suo diretto superiore. Stiamo banalizzando e non potrebbe essere altrimenti. Eppure – ed è un dato – un marocchino considera realmente la sua città, per dirla con i teorici della Scuola di Chicago, “il luogo ideale per la realizzazione degli individui”.
Di norma, invece, il cittadino di una grande metropoli occidentale, sia New York o Parigi, Madrid o Baltimora, considera il suo ambiente solo come uno dei tanti scenari possibili della sua esistenza, un luogo che anzi rischia di lasciar prevalere fattori di differenziazione ed emarginazione, e quindi diventare instabile.
Questa insofferenza nei confronti della propria condizione – e di più quando i confini del proprio sviluppo mentale e fisico sono circoscritti in un grande agglomerato urbano – suscita nel soggetto spaesamento, angoscia, terrore.
Citando ancora Park, diremmo: “In una città moderna si addensano una varietà e una quantità eccessiva di aree naturali in uno spazio relativamente limitato”. Ovvio smarrire i poli di interesse.
Io e Brian Huang iniziammo a interessarci agli studi di morfologia sociale, con particolare riferimento alle rappresentazioni collettive e alle determinazioni nello spazio e nel tempo degli insiemi che costituiscono la memoria individuale e collettiva, affascinati dalle tesi di Maurice Halbwachs.
Sociologo acutissimo e inspiegabilmente dimenticato, morto nel 1945 per mano dei nazisti, Halbwachs è stato divulgatore di alcune delle riflessioni più lucide e originali del secolo passato riguardo al problema della memoria.
Il ricordo individuale, per Halbwachs, non è il luogo della persistenza del passato, ma una ricostruzione selettiva mediata dai bisogni del presente e dipendente dai quadri del pensiero comune.
Halbwachs si ispirò ai testi di Henri Bergson, suo professore al liceo, il quale distingueva due forme di memoria: una intesa come acquisizione di una serie di operazioni concatenate e che si compiono nella distrazione che chiamò memoria-abitudine e un’altra, profondamente radicata nell’inconscio, definita memoria-immagine (o ricordo puro).
Halbwachs si spinse oltre.
A suo giudizio la memoria non può essere trattata come funzione psicologica di un singolo individuo. Il ricordo è un’azione che avviene nel presente e dal presente dipende e tramite esso si riattualizza. Il passato non si conserva tale e quale, ma si ricostruisce in base ai bisogni del momento.
Il livello più elementare dei quadri collettivi è il linguaggio. Il funzionamento stesso della memoria non è possibile senza quegli strumenti di base che sono le parole e le idee legate all’ambiente. È forse per questo che in una Base Profonda, per quanto frammentaria e lacunosa, si rintraccia sempre una base linguistica, anche se rudimentale?
(…)
Ma torniamo alla città, al contesto spaziale e alle sue influenze sulla memoria collettiva.
Uno dei quesiti che ci veniva posto con una certa frequenza durante i primi periodi di sperimentazione era come mai le Basi non restassero stabili.
Succedeva che, anche riconfigurazioni effettuate in condizioni ottimali e apparentemente riuscite, dopo un breve periodo di controllo emotivo tendevano ad alterarsi, spesso scindendosi in due o più identità.
Noi abbiamo sempre creduto che la spiegazione di questo fenomeno andasse ricercata in quello che Halbwachs chiama automatismo collettivo.
L’equilibrio mentale è dovuto, secondo il sociologo francese, al fatto che gli elementi e gli oggetti della realtà con la quale siamo in contatto tutti i giorni non cambiano o cambiano molto poco e ci offrono un’immagine permanente di stabilità.
 Traslando il medesimo concetto ai grandi spazi, un essere umano dà per scontato che l’aspetto della città nella quale vive rimanga immutato nel corso degli anni. L’immobilità del luogo urbano rinsalda le sue certezze. Così come i comportamenti ripetitivi.
Traslando il medesimo concetto ai grandi spazi, un essere umano dà per scontato che l’aspetto della città nella quale vive rimanga immutato nel corso degli anni. L’immobilità del luogo urbano rinsalda le sue certezze. Così come i comportamenti ripetitivi.
Anche se all’interno della metropoli si creano gruppi in continua evoluzione, gruppi nei quali il soggetto entra ed esce anche più volte al giorno (famiglia, ufficio, sport) ogni suo gesto e ogni suo pensiero si srotola sulla successione di palazzi, vie, incroci, parcheggi, alberi che restano lì, quasi identici. L’automatismo collettivo porta il gruppo sociale a ricercare zone, attività e abitudini stabili nel tempo.
Quindi, perché le nostre Basi Profonde, banalmente, impazzivano? Perché la persona riconfigurata smarriva qualsiasi riferimento spaziale e fisico!
Ci eravamo concentrati troppo sull’aspetto squisitamente medico, avevamo agito da positivisti. Si può tracciare una geografia mentale solamente sovrapponendo l’irreale al reale. I due elementi sono inscindibili.
Dal secondo capitolo: Il lettore avrà notato che il mio approccio è più rivolto alle scienze umanistiche che alle questioni scientifico-tecniche.
Al di là della sempre maggiore efficacia dei programmi messi a punto dagli informatici, restava qualcosa di irrisolto – almeno dal mio punto di vista – sul piano strettamente emotivo. Ne discutemmo per mesi quasi quotidianamente con il dottor Huang e con tutta l’equipe e più volte gli incontri terminarono in virulente litigate, porte sbattute e urla lungo i corridoi.
Ricordo bene che una notte, vagando per i vicoli della mia città, la mente alienata in parte dalle droghe e in parte da un’eccitazione febbrile che mi pervadeva, ebbi l’illuminazione (credo sia il termine adatto) di applicare un nuovo metodo di lavoro alla sequenza di riconfigurazione. Con in testa la teoria strutturalista di Levi-Strauss, convocai una riunione d’urgenza. Huang arrivò come sempre bestemmiando. Avevo interrotto un incontro galante con una delle sue studentesse. Il resto dei miei colleghi sembrava una ciurma di ubriaconi scalcagnati, piuttosto che un gruppo di scienziati.
Tra gli sbadigli, esposi la mia teoria.
Lo strutturalismo si basa su un assunto: per comprendere una società bisogna studiare i segmenti che la compongono.
Una struttura è una linea sovra individuale di lunga durata rispetto alla quale sono ininfluenti le vicende dei singoli. La struttura è costituita dalla materia informe della psiche.
Il fine di un’azione (azione intesa non come evento, ma come istituzione) ha sempre ripercussioni sul sistema generale.
Ecco come intendevo procedere: informatizzare le catene sinaptiche cercando di ricostruire la rete di ricordi seguendo una traiettoria progressiva dal più antico al più recente. Prima di digitalizzare una Base Profonda, dovevamo fondarne le basi, ritornare alle prime nozioni apprese dall’individuo, scavare l’humus della coscienza.
In un encefalo ogni impulso nervoso contribuisce a mantenere il sistema in equilibrio, esattamente come facevano, in una società arcaica, i comportamenti codificati osservati da Levi-Strauss.
Pensavamo di aver finalmente imboccato la strada giusta. Quella sera uscimmo dagli uffici euforici e ci sbronzammo. Scherzavamo tra noi dicendo che avevamo trovato il modo per regalare all’umanità una camera con vista sull’infinito.
Quanto ci sbagliavamo! Quale errore di presunzione stavamo commettendo!
Dopo nemmeno un anno di esperimenti (e dopo aver dilapidato milioni di dollari e aver fatto scappare quasi tutti i finanziatori) incappammo in quello che avremmo soprannominato “Il trabocchetto di Dio”.
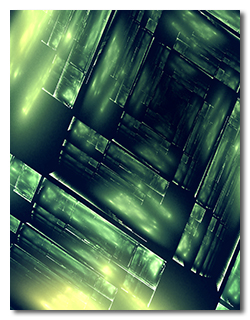 Mi destai urlando in una condizione psicofisica spaventosa, il corpo stremato dalla disidratazione. Provai a sollevare la testa. I tendini del collo scricchiolarono.
Mi destai urlando in una condizione psicofisica spaventosa, il corpo stremato dalla disidratazione. Provai a sollevare la testa. I tendini del collo scricchiolarono.
La mia gamba sinistra pulsava di dolore: un dolore rumoroso, lucente, compatto.
Ebbi appena il tempo di rendermi conto di essere vivo… scivolai nuovamente nell’incoscienza.
Pioveva.
Mi toccai la fronte.
Cercai il videofonino senza trovarlo.
Intravidi dei movimenti fuori dai finestrini… un volto bianchissimo… facce che mi spiavano come si osserva un pesce in un acquario.
La gamba… la temperatura all’interno della Toyota stava diventando insopportabile.
Afa soffocante.
Una donna e un bambino… dietro i vetri… sotto le lacrime del cielo…
Allungai una mano per afferrare quegli spettri.
Mi lasciai andare contro il sedile fradicio. Mi contorsi. Cercai la leva per abbassare la spalliera. Così andava meglio…
Caldo… confusione…
Gridai, sferrando calci al vuoto…
Il videofonino… Francesca… Astreana… il sole… la Pam… Astreana… Francesca… numeri a caso: mille, tre, cinquantadue, seicento.
Incubi di zampe palmate, pinne, salamandre. Incubi di un laboratorio da tassidermista.
Nella mia mente subentrò una visione terrificante che mi suggerì l’illusione di essere una povera anima in pena, solitaria e abbandonata a se stessa in un deserto sconfinato.
Il diluvio tamburellava monotonamente sulla lamiera. Smaniavo, sudavo.
 Aprii leggermente lo sportello, ma l’acqua schizzava dentro. Bevvi la pioggia.
Aprii leggermente lo sportello, ma l’acqua schizzava dentro. Bevvi la pioggia.
L’imbottitura del sedile era piena di ossa che facevano cloc cloc.
L’alba germogliò dai cumuli di pattume illuminando un cielo terso, indaco, depurato dall’acquazzone notturno.
Il luogo dell’incidente era una spianata depressa rispetto al piano stradale di una quindicina di metri. Il pantano si stendeva a perdita d’occhio. Sul versante opposto rispetto al muso della Toyota si ergeva un monumentale cavalcavia. Osservandolo dal basso, il viadotto assomigliava a un mastodontico essere preistorico, superiore e indifferente alle vite umane che strisciavano sulla Terra.
Mi accorsi di essere stato derubato quando notai il mio portafogli aperto nell’erba a qualche metro dall’auto, i documenti sparsi dappertutto. Durante il mio periodo di incoscienza a seguito dell’urto qualche sciacallo si era appropriato dei soldi e del videofonino. Un’autentica tragedia!
Quanto tempo fossi rimasto svenuto non avrei saputo quantificarlo. Probabilmente ore.
Con sofferenza estrema mi sfilai i calzoni. Poco sopra la caviglia la gamba era ridotta a un reticolo di vene e capillari tumefatti. Mi autodiagnosticai una frattura della tibia.
Spalancai lo sportello e vomitai bile in una pozza di fango.
In breve tempo mi convinsi che l’universo non esistesse al di fuori di quell’abitacolo. Ogni emozione, ogni anelito era racchiuso tra quei quattro montanti. Da lontano mi giungeva ovattato lo scorrere del traffico, una vibrazione quasi impercettibile. Il sole penetrava insolente attraverso il parabrezza scomponendosi in falci luminose.
Provai a riflettere, anche se i pensieri si intrecciavano.
Perché uscire? Perché provare a salvarsi?
Tutta la mia esistenza mi sembrava ridimensionata a un continuo susseguirsi di sterili domande.
Inutile, in definitiva.
Quella notte, rabbrividendo all’apogeo del delirio, mi era parso di vedere un essere gobbo e informe muoversi attorno alla Toyota.
La spossatezza mi aggredì come schiuma sporca. Non mangiavo da quanto, trenta ore?
Calo di glucosio… da quel momento in avanti non avrei più ragionato lucidamente, un velo opaco sarebbe calato sulle mie facoltà mentali fino a ottenebrarle.
E se l’auto avesse incominciato a sprofondare nella melma?
L’avevo visto innumerevoli volte nei film quando ero bambino: finivi nelle sabbie mobili ed eri fregato! Ci stiravi le zampe, poche storie! Non importa quanto tu fossi preparato e audace, quanto tu fossi fico, una volta messo il piede in fallo non avevi più via di scampo. Ultimamente, chissà perché, le sabbie mobili erano passate di moda e gli sceneggiatori l’avevano rinnegato come espediente narrativo. A me invece piacevano, rappresentavano il fascino della casualità, dell’imponderabile. L’unica possibilità di sopravvivenza era data da una canna cava di bambù che ti avrebbe consentito di respirare da sotto la superficie. Ma non sempre puoi avere a disposizione una canna cava di bambù da usare come boccaglio!
 Inoltre, nel caso in cui la Toyota fosse rimasta miracolosamente a galla (perché ero assolutamente certo che prima o poi avrebbe iniziato a inabissarsi) esisteva sempre la possibilità, per nulla peregrina, che i ratti mutati mi fiutassero e mi divorassero. Era ormai opinione comune che dalle fogne dei Mercati Generali i sorci avessero raggiunto la zona allagata, che si presentava come il posto ideale per riprodursi in santa pace in attesa di sferrare l’attacco definitivo alla società costituita.
Inoltre, nel caso in cui la Toyota fosse rimasta miracolosamente a galla (perché ero assolutamente certo che prima o poi avrebbe iniziato a inabissarsi) esisteva sempre la possibilità, per nulla peregrina, che i ratti mutati mi fiutassero e mi divorassero. Era ormai opinione comune che dalle fogne dei Mercati Generali i sorci avessero raggiunto la zona allagata, che si presentava come il posto ideale per riprodursi in santa pace in attesa di sferrare l’attacco definitivo alla società costituita.
Spalancai la portiera e zoppicando girai attorno alla Toyota.
Aprii il portabagagli e tra le cianfrusaglie rinvenni una coperta stile militare di lana grezza e un paio di guanti da giardiniere, con le palline di gomma dura sui polpastrelli.
Urlai e mi sbracciai poco convinto in direzione della strada, quindi mi sdraiai sul sedile posteriore, spossato.
Mi raggomitolai nella trapunta polverosa e rimasi a fissare il tettuccio, convinto di scorgere strani riverberi arancioni sulla plastica. Solo parzialmente consapevole di essere affetto da allucinazioni mi ritrovai, almeno un’ora dopo, a battere i denti e a contorcermi dal dolore.
Il mio alito cattivo mi ricadeva sulla faccia.
Mi stesi bocconi e udii nuovamente le voci…
“È vivo?”
Un bambino.
“Non lo so, probabile. Non toccare niente!”
Una giovane donna.
Ero certo si trattasse di Francesca. Non poteva essere altrimenti.
“Dobbiamo dirlo al Gran Maestro?”
“Penso di no, non gli interessa…”
“Perché non se ne va?”
“Non vedi come è ridotta la macchina?”
Poi, l’inchiostro.
Scavai più a fondo nel sedile per fargli assumere la mia forma. La posizione mi pareva comodissima, la più comoda che avessi mai provato. Volevo annullarmi, non avevo nemmeno bisogno di arrovellarmi alla ricerca di una soluzione, tanto una soluzione non esisteva.
 Dentro quella macchina mi sembrava di esserci nato. E ci sarei anche morto. Cos’altro poteva esistere all’infuori di quell’abitacolo, delle onde d’erba mosse dal vento, dell’odore dei copertoni bruciati, del terrapieno, del traffico?
Dentro quella macchina mi sembrava di esserci nato. E ci sarei anche morto. Cos’altro poteva esistere all’infuori di quell’abitacolo, delle onde d’erba mosse dal vento, dell’odore dei copertoni bruciati, del terrapieno, del traffico?
C’era Astreana. Sì, lei esisteva.
Non era stata l’unica donna della mia vita e nemmeno la più importante, però pensare a lei mi faceva stare bene. E questo bastava. Lei interagiva col mondo fuori, un mondo extraterrestre, un mondo disumano, un posto nel quale c’era stata un’esplosione che aveva raso al suolo le torri e i bastioni lasciando solo cenere e detriti.
Il resto erano ricordi indotti, falsi, sfocati. La Profonda è fuggevole: un vestito può cambiare colore, un nome perdere significato, perfino le sensazioni possono ribaltarsi.
La felicità non è altro che un’arma carica pronta a fare fuoco e a spargere le tue cervella sulle piastrelle rosse del pavimento della cucina. Piastrelle che ti sembra di aver scelto. Ti sembra perché non ci giureresti, non eri tu a decidere, tu eri incapace di intendere e di volere, dovevano ricoverarti, non portarti a spasso per mobilifici.
E se i racconti dell’Ispettore non fossero stati, appunto, nient’altro che le chiacchiere alterate di uno squilibrato? Ci eravamo bevuti ogni elemento, ogni vaga ipotesi, ogni congettura. Quale certezza avevamo che non stessimo assecondando le fantasie perverse di un folle?
Una Base Profonda è una Base Profonda, perché darle più importanza del dovuto?
Alberto Amodio aveva massacrato la fidanzata e si era ucciso in carcere, questo era un dato di fatto incontrovertibile. La sua famiglia ne aveva preso le distanze sin dal primo giorno, lasciandolo solo e sconvolto tra le grinfie di giornalisti, avvocati in cerca di pubblicità e stralunati ammiratori. Attorno a quel poveraccio mitomane si era radunata una quantità di parvenu da far invidia al più ostinato messia demente rigurgitato dalla zona allagata. Pace all’anima sua e tutto era finito in gloria.
Le supposizioni e i “bla bla” da osteria non erano prove.
Potevano fomentare i maniaci del complotto e far vendere qualche copia in più a una furba casa editrice che avesse lanciato sul mercato il solito, immancabile libro-verità sulla vicenda, ma chi concretamente si sarebbe messo in gioco per smentire ciò che un tribunale aveva sancito?
Era una macelleria, altro che scoop dell’anno.
In questa vicenda che ruolo ricoprivano le mostruosità del mio incubo? Probabilmente nessuno. Si trattava del parto di una mente sovraccarica.
Eppure… un fastidio strisciante mi accompagnava da quella notte.
Ma invece di pensare all’Ispettore e a Amodio, non avrei dovuto concentrare i miei sforzi fisici e intellettivi per salvarmi? Volevo crepare sul divano posteriore di quell’auto?
Maledizione! Maledizione! Non riuscivo a interrompere il flusso delle percezioni, al tempo stesso esaltanti e torbide, che mi pervadevano.
Il pesce con le fauci sdentate e slabbrate dagli uncini, l’insetto dalle ali posticce e la proboscide a girandola, l’essere con le ossa invertite e l’aborto con gli innesti sferici sottopelle… eccoli lì, si aggiravano attorno alla Toyota come un branco di avvoltoi in cerchio su una carcassa.
Volevano entrare e cibarsi delle mie carni, sarebbe stata per loro un’esperienza inebriante.
 Mio nonno era stato un vero veggente.
Mio nonno era stato un vero veggente.
Il potere salta una generazione, difatti mia madre non ha mai avuto alcuna premonizione, mentre io iniziai a vedere il futuro sin da bambino. Ma la mia ricettività era ben poca cosa, la si sarebbe potuta considerare appena più influente di una spiccata sensibilità. La vera divinazione era stata certamente tramandata ai due Tagliaferri che, prima della mia nascita, morirono intrecciati nel ventre materno.
Crescendo la mia capacità si affievolì sin quasi a scomparire.
“Se la tua mente è chiusa, se poni un argine tra te e le energie ultraterrene che ti aggrediranno, allora diventerai come il resto del mondo, muto e in balia degli eventi” diceva.
Avevo troppa paura di essere considerato un diverso e feci in modo di dimenticarmi delle mie visioni oracolari. Mi feci muto e rimasi in balia degli eventi, come tutti i miei sventurati simili.
Il giorno successivo alla morte di mio nonno – avvenuta nel suo letto in grande tranquillità e compostezza – sul villaggio piovvero aghi di pino.
Tapparono i comignoli, bloccarono le porte, si infilarono dappertutto: nelle tasche dei vestiti riposti negli armadi, dentro le scarpe, tra le pagine di una bibbia dimenticata sulla panca della chiesa. La fragranza pungente della resina rimase nell’aria per settimane.
Mi schiacciai contro il finestrino e d’un tratto qualcosa si mosse alla destra del mio campo visivo, un’alterazione al limite della visione periferica.
“C’è qualcuno? Aiuto!”
Una testolina spuntò tra le spirali d’erba.
“Chiama i soccorsi… la gamba!”
Il ragazzino si dileguò, sagoma incerta stagliata contro il verde immenso.
Qualcuno stava tirando dei sassi contro l’auto, cercando di attirare la mia attenzione.
Rinvigorito dalla presenza di un altro essere umano, ingagliardito dalla novità, decisi di scendere. Lo sconosciuto aveva lasciato un bastone dall’aspetto solido appoggiato alla Toyota. Evidentemente mi aveva spiato e si era accorto che zoppicavo.
Il bambino si avvicinò fino a una decina di metri e, nonostante il buio, ne distinsi i lineamenti delicati. Indossava un maglione a girocollo e guanti bianchi.
Come in uno strano sogno, mi addentrai nella campagna, in quello spazio vuoto tra la città e il mare, in quella marginale terra di nessuno popolata da spettri. Procedevo tra i fusti tossici scaricati lì da decenni, nell’acquitrino molle e inquinato nel quale le mie scarpe affondavano, vagabondavo in quell’universo di prostrazione, in quella palude ribollente, con le narici impregnate dell’odore di olio e di muschio.
Smarrii quasi immediatamente le Basi del mio salvatore.
Afflitto dall’idea di perdere me stesso tra le volute bluastre di quel pantano, non mi accorsi del muro di cinta del cimitero fin quando praticamente non ci inciampai. La malta e i mattoni si erano sbriciolati da tempo immemorabile e non faticai a rintracciare un varco. Mi infilai nel pertugio senza pensarci.
 Mi mossi tra le tombe con una sensazione di irrealtà. Il bastone mi forniva un valido sostegno. Esplorai l’area alla tenue fiammella dell’accendino che portavo sempre in tasca per aprire le birre.
Mi mossi tra le tombe con una sensazione di irrealtà. Il bastone mi forniva un valido sostegno. Esplorai l’area alla tenue fiammella dell’accendino che portavo sempre in tasca per aprire le birre.
Le lapidi erano divelte, i fiori appassiti. Sul camposanto incombeva un’aura di mestizia e abbandono. Gli spigoli di alcune bare emergevano dalle profondità, evidentemente smosse da assestamenti sotterranei. Tutta quella zona era imbevuta d’acqua come una spugna in una vasca.
Unicamente un angelo di cemento resisteva alla corrosione del tempo, vegliando il sonno inquieto di quei morti senza nome.
Trovai rifugio in una cappella, la cui porta di legno marcio giaceva sui gradini d’ingresso.
Scivolai in un sonno intermittente e pieno di sospiri.
La mattina successiva fui destato dal fragore della pioggia.
Nottetempo, qualcuno si era intrufolato nel tempietto e mi aveva lasciato del pane, delle scatolette di carne gelatinosa e dell’acqua.
Mangiai e nelle ore successive riacquistai un po’ di energia. Avevo la bocca piena di afte.
Trascorsi il tempo a guardare il cielo di alluminio fasciato dalle luci spettrali dei lampi. Le pozzanghere diventavano via via più ampie e profonde. Mai come in quel momento ringraziai Dio per avermi concesso di ripararmi sotto quel tetto.
Un cane idrofobo attraversò il cimitero guardandosi intorno con gli occhi iniettati di pus e il respiro mozzo. La sua magrezza era strabiliante: aveva il pelo lacero e il muso ammaccato. Non mi notò e scomparve oltre il cancello.
Per uno stupido vezzo scribacchiai una frase col nerofumo dell’accendino sulla volta della cappella.
Manlio…
Mi ritrovai adolescente, i capelli arruffati, le mani sporche e l’apparecchio ai denti, stremato da giornate trascorse sul sellino della mountain bike avanti e indietro lungo i vicoli del paesino dove passavo l’estate.
…D’Altavilla…
Dopocena, mentre si preparava il caffè, mio nonno mi prendeva da parte e mi mostrava le fotografie sgranate in bianco e nero degli altri componenti della famiglia che avevano convissuto con la veggenza.
Le stanze della grande casa di campagna odoravano di liquore e sugo. E di naftalina quando si aprivano gli armadi.
…è…
Durante le notti di vento le visioni del nonno si facevano più intense. Anche se la mia camera da letto si trovava dalla parte opposta del corridoio, potevo lo stesso udire i suoi gemiti, frammisti alle preghiere della moglie e agli scricchiolii della scala di legno. Mettevo la testa sotto il cuscino e cercavo di concentrarmi unicamente sull’ululato prodotto dalle folate che si insinuavano fra le tegole e spazzavano il portico.
…nato…
Ingoiavo lacrime silenziose. Non volevo ridurmi in quello stato, volevo vivere nella spensieratezza un po’ superficiale dei miei compagni.
…qui.
 Un’ora dopo l’altra, confuso dai lugubri barlumi delle reminiscenze infantili, non mi accorsi delle cataclismatiche condizioni meteorologiche e iniziai a preoccuparmi solo quando l’acqua raggiunse il primo scalino della cappella.
Un’ora dopo l’altra, confuso dai lugubri barlumi delle reminiscenze infantili, non mi accorsi delle cataclismatiche condizioni meteorologiche e iniziai a preoccuparmi solo quando l’acqua raggiunse il primo scalino della cappella.
Il drenaggio in quella zona stagnante era pressoché nullo e dopo ventiquattrore di temporale ininterrotto il cimitero si era tramutato in una grande piscina. Il diluvio mugghiava e ruggiva come una fiera alla catena.
Attesi in silenzio, pregando che la smettesse.
Invece la volta celeste fece crack e venne giù l’Armaggeddon.
Scosso dai tremori dovuti ai vestiti bagnati e al deperimento, mi accucciai il più possibile sul fondo alla cappella.
Che fare? Uscendo mi sarei trovato in balia degli elementi, senza un riparo e immerso nel fango fino alle cosce. L’intero Creato sembrava fatto d’acqua…
Quando un rivolo gelido si insinuò nella mia piccola grotta, persi la testa.
No!
Non potevo morire, non prima di aver trovato la Base di Francesca, prima di averle parlato, di averle fatto delle domande… non era giusto! Chiedevo solo un posticipo alla mia dipartita, poi sarei anche potuto crepare tra sofferenze inaudite, non mi importava!
Dio, strappami i nervi uno a uno, ma consentimi di parlare ancora una volta con mia figlia! Una sola volta! Una-sola-schifosissima-volta!
Fuori dal tempietto mi trovai di fronte all’apocalisse.
Venni investito dal tanfo di cloache stracariche e bitume.
Finii con la faccia nella poltiglia composta dal limo, dalle secrezioni dovute alla decomposizione dei cadaveri e dalle schifezze velenose riversate nel Tevere e ormai assorbite dalle falde.
In parte nuotai, in parte mi spinsi in avanti ficcando le dita nel fondo molliccio.
Mi aggrappai all’unico appiglio che vedessi, l’angelo.
Riuscii a issarmi sul basamento della statua, anche se il dolore alla gamba mi faceva sussultare e avevo le braccia molli come plastilina.
Prima o poi sarebbe tornata la luce, ma a che pro? Il freddo, l’umidità e la notte mi erano penetrati così a fondo che nemmeno il sole equatoriale mi avrebbe riscaldato. Mai un uomo aveva ingoiato tanta solitudine.
Cosa restava di me, di Manlio D’Altavilla?
 Espulsa dal suo alloggiamento, una cassa da morto cozzò contro il sostegno della statua. Nella sua anima di zinco deformata dai gas si aprì una ferita sibilante. Le ossa marce si allargarono in cerchio. Osservai la scena con occhi enormi, scandalizzato dall’orrore.
Espulsa dal suo alloggiamento, una cassa da morto cozzò contro il sostegno della statua. Nella sua anima di zinco deformata dai gas si aprì una ferita sibilante. Le ossa marce si allargarono in cerchio. Osservai la scena con occhi enormi, scandalizzato dall’orrore.
Altre bare galleggiarono l’una contro l’altra, fracassandosi, come in un autoscontro delirante.
In breve la pozza ai miei piedi si ridusse a un brodo putrido nel quale andavano alla deriva tibie e femori, ulne e costole, crani, schegge di legno e lastre di zinco martoriate.
Urlai rivolto all’entità cattiva e sadica che mi stava torturando: “Perché non la fai finita, eh? Perché non mi ammazzi?”
Mi rannicchiai ancora di più sotto le ali protettrici dell’angelo, l’abbracciai come si stringe la donna amata dopo una giornata di delusioni. Il cemento era solido contro la mia guancia. Era tangibile, ed era già una conquista.
Dopodiché, persi la ragione…
Una creatura mostruosa con un buco nella fronte, immersa in quel mare infetto fino all’ombelico, protendeva le sue braccia muscolose e smisurate verso di me…
.
.
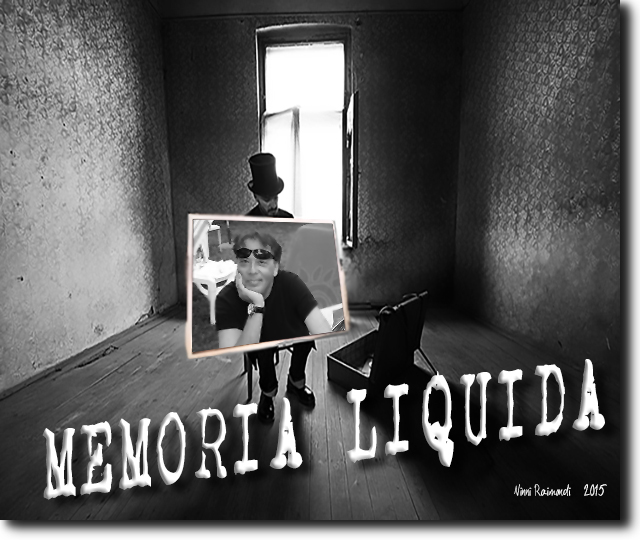




Buongiorno a tutti
"Mi piace""Mi piace"
Ciao
"Mi piace""Mi piace"
Un capitolo, altamente, intellettuale che va seguito e letto, con estrema attenzione. Ovviamente, ho letto in questo brano, la tua passione per l’Antropologia.
Sarà, ma vedo un nesso tra la vicenda di Cinzia e l’incidente da incubo subito.
Comunque, questo, è un Capitolo bellissimo.
Ciao
"Mi piace""Mi piace"
L’ho letto in due riprese.
Avevo la tazzina in mano e ho iniziato con l’interesse solito. Ma arrivata al terzo o quarto rigo, mi sono fermata. la lettura mertava di più. Ho terminato il mio caffè e mi sono accomodata, meglio, con il tablet tra le mani.
E’ divino, Ninni milord del mio cuore.
Bello, complesso e soprattutto, profondo. Il riportare quanto scritto nel ibro dello scienziato e leggere la disavventura di Manlio, mi ha iluminata, sia nella storia, sia nella letteratura, che oggi è profonda.
Bello, bellissimo.
Ciao e buon sabato
"Mi piace""Mi piace"
L’ho riletto questa mattina con la mente più sgombera. Mi sono rilassata nella lettura tenue e leggera. Ninni, mi ha presa per mano e mi hai offerto quel libro dello scienziato.
Mi hai, gentilmente, messa a mio agio, nascosta dentro quel cimitero mentre si evolveva la situazione.
Incredibile il sapore che prende la rilettura un giorno dopo.
Buona domenica.
🙂
Giorgia
"Mi piace""Mi piace"
Molto molto profondo e rgionato.
Non me l’aspettavo, ma la tua bravura dveva mettermi in allarme.
Bello, un bacio e buon sabato “Ninni milord del mio cuore”.
(ah hah ah ah ah ahha aha )
🙂
Buona giornata
"Mi piace""Mi piace"
Notevole è dirne poco. Efficacissima la citazione dal libro.
Comlimenti, un capitolobello
"Mi piace""Mi piace"
Un bel Capitolo. Rassicurante nelle spiegazioni sociali.
La piega che prende, però,indica uno stadio avanzato nella drammaticità stessa del racconto.
Buona sera
"Mi piace""Mi piace"
Contorto ma credibile.
Alla leggera fai parlare il professorone che, però, alla fine ne spiega e fa capire tanto.
Sembra che tu ci abbia dorito dentro a un cimitero
🙂
"Mi piace""Mi piace"
L’ho letto con calma e attenzione.
Ciao.
🙂
"Mi piace""Mi piace"
Questo capitolo, amico mio, è una vittoria su tutti i fronti.
Ciao
"Mi piace""Mi piace"
Un capitolo splendido e delirante!
"Mi piace""Mi piace"
Grande capitolo!!!
"Mi piace""Mi piace"
Una bellissima domenica con un capitolo bellissimo, caro milord.
buona giornata dalla partenope capitale.
Dudù
"Mi piace""Mi piace"
Questo romanzo non si basa più sul rispetto delle norme tradizionaliste: non c’è un inizio quiete, ma l’inizio di una guerra e il susseguirsi di peripezie dietro a tantissimi risvolti introspettici.
Mi ha affascinato l’ispettore e la figura di Manlio (bravo e maledetto).
Mi avvincono.
Non vedo l’ora del prossimo.
Ciao
Lilly
"Mi piace""Mi piace"
Soltanto e unicamente per motivi di tempo, improrogabili, vi ringraziammo in circolarità.
Saremo opportuni dal prossimo capitolo. Grazie per la comprensione e buona settimana.
"Mi piace""Mi piace"
Comprensione? Niet! 🙂
"Mi piace""Mi piace"
🙂
"Mi piace""Mi piace"